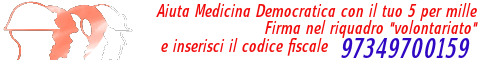SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 294 DEL 19/02/18
INDICE
- L’emergenza nazionale degli omicidi sul lavoro: intervista a Marco Spezia
- Tra polvere e ricatti: lavorare alla Eternit di Casale Monferrato
- Imparare dagli errori: quando i piedi non sono protetti
- Sull’utilizzo prioritario dei Dispositivi di Protezione Collettiva rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuali
- La prevenzione dei rischi per i lavoratori immigrati
Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.
La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.
L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.
Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”
Medicina Democratica – Movimento di lotta per la salute onlus
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
——————————————-
L’EMERGENZA NAZIONALE DEGLI OMICIDI SUL LAVORO: INTERVISTA A MARCO SPEZIA
Dal Partito dei CARC
Marco Spezia è un compagno che si occupa da una vita per professione, per mestiere, per passione e come contributo alla lotta di classe, della sicurezza suoi luoghi di lavoro. E’ promotore e curatore di Know your rights, una pubblicazione telematica che raccoglie le “newsletters” bollettini di informazione tecnico-legali sul diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e le “lettere dal fronte” del lavoro, testimonianze, commenti, riflessioni, spunti che “dal basso” trattano più in generale la questione del diritto al lavoro e del diritto alla salute e sicurezza non solo sul lavoro, ma anche sul territorio (per iscriversi alla newsletter: sp-mail@libero.it).
Nel mese di gennaio ha tenuto a Massa, in collaborazione con la Sezione del P.CARC, un’iniziativa rivolta tanto agli operai, quanto agli studenti (che “sul fronte del lavoro” ci finiscono per la famigerata Alternanza, senza alcuna preparazione, usati come carne da macello per il profitto) e da quella iniziativa prendiamo spunto per questa intervista.
MARCO, LA TUA ESPERIENZA E’ PIÙ ATTENDIBILE DI OGNI STATISTICA UFFICIALE: ESISTE NEL NOSTRO PAESE UN PROBLEMA DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO? DI CHE DIMENSIONI? E’ VERO CHE “LE COSE VANNO MEGLIO” O PENSI CHE IL LIVELLI DI DISOCCUPAZIONE INCIDA SULLE STATISTICHE UFFICIALI? INFINE, C’E’ UNA CORRELAZIONE FRA DISOCCUPAZIONE, PRECARIETA’ E DIMINUZIONE DELLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO?
Innanzitutto nel nostro paese più che un problema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dobbiamo parlare di emergenza quotidiana. Non c’è infatti giorno che in Italia non vi siano (in media) almeno quattro infortuni mortali: 1.350 morti all’anno per il 2017, considerando sia i morti sul posto di lavoro, sia i morti in itinere o su mezzi di trasporto..
Tale valore è ripreso dall’Osservatorio Indipendente Morti sul Lavoro di Carlo Soricelli (http://cadutisullavoro.blogspot.it) ed è un dato decisamente più attendibile di quelli diffusi dall’INAIL (per i motivi che vedremo dopo).
Oltre a queste morti, ogni giorno ve ne sono altrettante a causa di malattie professionali, quindi contratte per la insalubrità dei luoghi e delle condizioni di lavoro, per un totale di 1.350 morti (fonti Osservatorio Vega Engineering https://www.vegaengineering.com per il 2016).
E ancora, si contano ogni anno 420.000 infortuni, molti dei quali invalidanti (1.400 al giorno, 3 al minuto!) e 60.000 denuncie di malattie professionale (dati per il 2016, sempre da Vega Engineering).
E’ evidente che stiamo parlando di una vera e propria guerra contro i lavoratori!
In merito all’attendibilità delle fonti ufficiali (dati INAIL), è evidente che esse non possono essere veritiere, per il semplice fatto che si riferiscono esclusivamente a lavoratori assicurati INAIL e quindi non considerano minimamente l’esercito di Partite IVA individuali, lavoratori in nero, pensionati che continuano a lavorare perché non riescono a tirare avanti. Non considerano quindi tutti quei lavoratori atipici che per evidenti regioni di flessibilità sono invece in aumento.
L’Osservatorio Indipendente Morti sul Lavoro considera invece, mediante un capillare e certosina raccolta dati in tutta Italia, tutti i lavoratori, compresi quelli atipici.
Ed è per questo che l’Osservatorio è decisamente più veritiero è fotografa una realtà che non vede nessun miglioramento nel numero dei morti sul lavoro, ma sostanzialmente un andamento costante negli anni.
Se si considerano infatti il solo andamento dei morti sul posto di lavoro (che meglio fotografa le condizioni legate al rapporto di lavoro e ai luoghi e alle condizioni in cui si svolge), i numeri sono i seguenti:
2008: 640
2009: 550
2010: 560
2011: 665
2012: 620
2013: 590
2014: 665
2015: 655
2016: 640
2017: 630
E’ evidente che i “miglioramenti” sbandierati dall’INAIL (e che tengono appunto conto dei soli assicurati INAIL) e fatti propri per scopi di comodo da politici e sindacalisti di regime, nella realtà lavorativa non vi sono.
Guardando i dati INAIL, si può infatti vedere un trend di miglioramento, con una diminuzione dei morti per infortuni sul lavoro. Questo apparente miglioramento è dovuto proprio ai motivi sopra detti: si considerano infatti solo gli assicurati INAIL che sono in costante diminuzione, mentre si tralasciano i lavoratori atipici (Partite IVA, lavoratori in nero), che sono in aumento e che tra l’altro svolgono le lavorazioni più a rischio.
In merito alla precarietà, non c’è dubbio che essa non fa altro che peggiorare la situazioni in merito alla sicurezza. Al di là di considerazioni in merito alla minore professionalità (anche in termini di sicurezza) che il lavoro precario comporta, i lavoratori precari sono spaventosamente ricattabili e lo sono molto di più dei lavoratori a tempo indeterminato. Di fronte a situazioni di pericolo preferiscono tacere, per timore di finire nel mirino del datore di lavoro, rischiando il posto di lavoro.
PIU’ CHE UNA IMPRESSIONE, E’ UNA REALTA’: SI PARLA MOLTO DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE, MA AUTORITA’ E ISTITUZIONI FANNO POCO, PER NON DIRE NIENTE. POI CI SONO GLI INCIDENTI ECLATANTI, COME QUELLO ALLA LAMINA DI MILANO, ALLORA SI LEVA UN’ONDA DI DICHIARAZIONI ACCORATE, APPELLI, RICHIESTE… COSA C’È CHE NON VA?
Effettivamente i numeri che abbiamo sopra visto sono spaventosi. Come detto si tratta di una vera e propria guerra quotidiana che dovrebbe chiamare tutte le istituzioni a intervenire in maniera decisa. Ma al di là di qualche ipocrita dichiarazione nei casi più eclatanti e mediaticamente rilavanti, non si fa niente.
Eppure, da un punto di vista legislativo, l’Italia è sempre stata all’avanguardia nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Già la Costituzione stabiliva il diritto alla tutela del lavoratore e dopo di essa le prime leggi degli anni ‘50 hanno fissato regole stringenti per i datori di lavoro per tutelare i propri dipendenti.
Da dieci anni siamo poi arrivati al Testo Unico sulla sicurezza (il D.Lgs. 81/08) che assieme appunto alle fonti del diritto (Codice Civile, Codice Penale e Costituzione) costituisce una importante forma di tutela per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Oltre alle fonti legislative, la tecnica della sicurezza ha raggiunto elevatissimi livelli di tutela su tutti i campi (macchine, impianti elettrici, sicurezza antincendio, ecc.) con norme tecniche di altissimo livello.
Qual è dunque il motivo, se le leggi e le norme tecniche ci sono, perché si continui a morire e ad ammalarsi sul lavoro?
La risposta è semplice ed è la stessa che si ripete ogni qual volta si cerchi di proteggere gli sfruttati: la legge c’è ed è buona, ma volutamente non si applica e volutamente non si fa niente per farla applicare.
I motivi della mancata applicazione della normativa sono molteplici, ma riconducibili tutti a una causa principale: la concezione capitalista del lavoro che mette in primo piano la logica del profitto, al di là ogni altra considerazione etica o morale.
Il fatto è che creare le condizioni perché il lavoro sia sicuro e salubre ha un costo, per giunta un costo non produttivo, perché non è finalizzato alla crescita dei ricavi. Tutti questi maggiori costi come già detto non comportano una maggiore produttività e quindi non comportano un maggiore profitto, inteso come differenza tra ricavato della vendita e costo di produzione.
Per dirla con Karl Marx “Al padrone non interessa nulla della vita e della salute dell’operaio, se non ci sono le leggi che glielo impongono”.
Ma questa imposizione, nonostante che le leggi ci siano, di fatto non sussiste, oppure sussiste in maniera percentualmente irrilevante.
In conclusione, mancando la coercizione a “fare sicurezza”, i padroni non la fanno, riducendo il costo del lavoro e aumentando il loro profitto, unica leva dell’economia capitalista.
Questa logica non interessa solo i datori di lavoro, ma coinvolge (con i dovuti distinguo) anche le associazioni e le istituzioni che dovrebbero vigilare sul corretto adempimento della normativa o che dovrebbero punire i mancati adempimenti ai sensi della normativa stessa, in quanto tali istituzioni cono comunque sotto il controllo diretto o indiretto dei centri di potere capitalistico finanziario o industriale.
Di conseguenza:
- i partiti politici, anche quelli della cosiddetta “sinistra”, salvo casi rari, non inquadrano la mancata tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in un ambito più ampio di lotta di classe;
- i sindacati concertativi, accettando il ricatto “lavoro-sicurezza”, non supportano in maniera adeguata i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (figura prevista dalla stessa normativa), né pongono al centro delle loro vertenze il diritto alla salute e alla sicurezza;
- gli Organi di Vigilanza, anche a causa dell’endemica carenza di organico, eseguono le ispezioni delle aziende e dei cantieri in maniera saltuaria e spesso in maniera estremamente blanda o peggio concordata con i datori di lavoro;
- gli Organi Giudiziari, oltre ad essere ingolfati dalla lentezza dei processi (che spesso comportano la prescrizione del reato), in molti casi stanno dalla parte degli assassini, con la conseguenza di scandalose assoluzioni, anche in casi di evidente colpevolezza;
- la maggioranza poi dei lavoratori stessi ha perso ogni nozione di lotta di classe, non comprendendo che essa si manifesta ancora oggi, anche se in forme diverse rispetto al passato, con la netta contrapposizione tra chi lavorando rischia di morire e chi non fa niente per evitarlo.
NON NASCONDIAMOCI, CI SONO MOLTE SITUAZIONI IN CUI GLI OPERAI STESSI, TRATTANDO L’ARGOMENTO, CONCLUDONO CHE SE CI SONO INCIDENTI E’ ANCHE PER NEGLIGENZA E SUPERFICIALITA’ DEL SINGOLO LAVORATORE. QUI SI APRONO DUE QUESTIONI: LA PRIMA E’ DI CARATTERE POLITICO, NEL SENSO CHE ANNI DI CONCERTAZIONE SINDACALE, DI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE DI INTERESSI INCONCILIABILI FRA PADRONI E OPERAI, ANNI IN CUI LA CLASSE OPERAIA E’ STATA DISARMATA IDEOLOGICAMENTE E POLITICAMENTE HANNO CREATO UNA SITUAZIONE IN CUI FRA I DIPENDENTI STESSI SI E’ FATTA STRADA L’IDEA CHE “TUTTO DIPENDE DALLA CONDOTTA INDIVIDUALE”, CIOE’ I RAPPORTI DI SOTTOMISSIONE, I RICATTI IMPLICITI, LE DIRETTIVE NON SCRITTE SONO CONSIDERATE “NORMALITA’”, QUINDI LE RESPONSABILITA’ SONO INDIVIDUALI, SONO DI CHI “DOVEVA PRESTARE ATTENZIONE”…
Di fatto si è creata una sorta di accettazione.
La concertazione ha portato alla consapevolezza che per difendere il proprio lavoro e il proprio salario, si debba accettare tutto, anche la pericolosità delle condizioni di lavoro.
In questa mentalità di rassegnazione da parte dei lavoratori, ha avuto gioco forza la mistificazione portata avanti dai padroni, secondo la quale la sicurezza dipende dal lavoratore ed è lui che se sbaglia deve pagare (quante volte le cronache parlano di “errore umano” a proposito degli infortuni), come se uno sbaglio sul lavoro non fosse tollerabile.
Il lavoratore ha perso di vista il contesto all’interno del quale opera (macchinari e impianti non a norma, luoghi di lavoro insicuri, cadenze lavorative inaccettabili) oppure lo ha accettato come non modificabile ed è stato forzato a vedere soltanto il suo comportamento come possibile fonte di rischio.
In generale il lavoratore, come tutti i cittadini, in mancanza di reali movimenti politici e sindacali che li ponessero al centro delle lotte, ha perso di vista i valori fondamentali del lavoro e della vita: dignità, rispetto, salute, sicurezza, sostituiti dai valori effimeri del capitale.
LA SECONDA QUESTIONE E’ CHE EFFETTIVAMENTE, COMPLICI ANCHE I SINDACATI DI REGIME, E’ VENUTA MENO LA FORMAZIONE, LA CONOSCENZA DI LEGGI, PROCEDURE, DIRITTI, COMPORTAMENTI PER TUTELARE L’INTEGRITA’ E LA SALUTE DEI LAVORATORI. E QUESTO SI TRATTA PRINCIPALMENTE CON LA FORMAZIONE, L’EDUCAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE NELLE AZIENDE, A PRESCINDERE DAI SINDACATI, DALLE SIGLE, ECC…
La legislazione prevede come una delle misure fondamentali di tutela della salute e della sicurezza, l’informazione e la formazione dei lavoratori.
Il problema è che questa viene fatta da figure aziendali o da consulenti pagati dalle aziende e si riconduce quindi a una serie di nozioni a uso e consumo dei padroni (quando viene fatta realmente…).
Effettivamente una vera consapevolezza della cultura della sicurezza che, partendo dalle nozioni legislative, normative e tecniche, spieghi al lavoratori quali sono i doveri dei datori di lavoro e quindi i diritti dei lavoratori manca.
Manca inoltre una crescita culturale dei lavoratori che inserisca anche la mancata sicurezza sul lavoro in un’ottica più ampia di lotta di classe, in cui da una parte stanno le aziende con la loro sete di profitto (e quindi di riduzione di qualunque costo non produttivo, come la sicurezza), da una parte stanno i lavoratori salariati o i lavoratori autonomi che accrescono (anche con il lavoro insicuro) i profitti dell’azienda.
NOI PENSIAMO CHE I PRIMI PROMOTORI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUBRITA’ SUI LUOGHI DI LAVORO DEBBANO ESSERE GLI OPERAI STESSI: E’ L’UNICO MODO PER FAR VALERE LEGGI E REGOLAMENTI CHE ALTRIMENTI RIMANGONO CARTA STRACCIA. INSOMMA: E’ GIUSTO, MA NON BASTA, APPELLARSI ALLE ISTITUZIONI. COME SI FAVORISCE IL CONTROLLO POPOLARE DELLA SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO?
La legislazione dà (almeno in teoria) molte possibilità perché i lavoratori facciano valere i propri diritti.
I lavoratori possono eleggere i propri Rappresentanti della Sicurezza (RLS) che, a loro volta, in caso di inadempienze non risolte da parte dell’azienda, possono richiedere l’intervento degli Organismi di Vigilanza (ASL e Vigili del Fuoco) ed eventualmente rivolgersi alla Procura della Repubblica.
Inoltre anche il singolo lavoratore può segnalare la presenza di un reato (e qualunque inadempimento alla normativa di salute e sicurezza è un reato).
Il problema è che il singolo RLS o il singolo lavoratore, oltre ad essere ricattabili e facilmente “eliminabili” da parte dell’azienda, non hanno il peso sufficiente a smuovere istituzioni quali gli Organi di Vigilanza o Giudiziari.
Torniamo quindi a quanto detto prima.
Occorre creare nuovamente tra i lavoratori consapevolezza dei propri diritti, dei propri valori e della propria forza.
Storicamente soltanto nelle realtà lavorative dove i lavoratori hanno fatto “massa critica” ci sono stati dei miglioramenti delle condizioni di lavoro.
Solo se i lavoratori si presentano numerosi, uniti e con le idee chiare su cosa vogliono ottenere per un lavoro salubre e sicuro, potranno avere peso nei confronti non solo dell’azienda, ma anche delle istituzioni, degli Organi di Vigilanza e Giudiziari, dell’opinione pubblica.
ULTIMA DOMANDA. L’INIZIATIVA CHE HAI TENUTO A MASSA E’ SECONDO NOI UN ESEMPIO MOLTO POSITIVO. SEI DISPOSTO A PARTECIPARE A INIZIATIVE SIMILI IN LOMBARDIA?
Assolutamente sì.
Il mio progetto vuole contribuire a fare cultura sulla sicurezza nei lavoratori e nei loro rappresentanti. Ma non quella cultura che insegnano i datori di lavoro nei corsi di formazione “istituzionali” che vede nel lavoratore l’unico responsabile della sua sicurezza, bensì una cultura che parta da una considerazione di classe secondo la quale l’unico interesse del datore di lavoro, cioè del padrone, è il profitto, anche sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini.
Ed è quindi solo combattendo questo concetto produttivo che si può sperare di migliorare le condizioni di lavoro.
Sono sempre stato disponibile a partecipare a iniziative di formazione e di sensibilizzazione sui temi della tutela della salute e della sicurezza promosse da movimenti politici e sindacali che hanno a cuore i diritti dei lavoratori e dei cittadini.
NON MI TIRO CERTO INDIETRO.
——————————————-
TRA POLVERE E RICATTI: LAVORARE ALLA ETERNIT DI CASALE MONFERRATO
Da Rivista Pandora
01/02/18
di Rebecca Paraciani
Continua la serie di articoli sul cruciale tema dell’amianto in Italia, dopo un primo contributo che ha ripercorso l’origine dell’industria dell’amianto e analizzato la diffusione della consapevolezza dei suoi rischi e le parallele strategie messe in atto dai consorzi dei produttori per difendere i grandi profitti che il settore garantiva. Questo articolo si prefigge di ricostruire il caso dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, evidenziando le condizioni di lavoro al suo interno ed il ruolo avuto dalla vicenda nel processo che ha portato alla messa al bando dell’amianto in Italia.
Le informazioni relative alle modalità di produzione e alle condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento sono derivate dalla raccolta di testimonianze di ex lavoratori, ex lavoratrici e familiari di lavoratori e lavoratrici della Eternit di Casale. Fanno riferimento alle modalità di produzione di materiali in cemento-amianto messe in atto dallo stabilimento dagli anni del secondo dopoguerra fino alla sua chiusura.
Casale Monferrato è una cittadina in provincia di Alessandria. A partire dal 1907 viene scelta per la sua posizione al centro del triangolo commerciale Genova-Torino-Milano per ospitare lo stabilimento Eternit, costola della Eternit SpA dell’Europa continentale e di proprietà dell’ingegnere Mazza, che nel 1911, con la sua invenzione di impianti per tubi per condotte a pressione, eleverà la fama internazionale della fabbrica. La società verrà quotata in borsa e lo stabilimento sarà talmente produttivo da non cessare la propria attività nemmeno durante gli anni delle due guerre, a seguito delle quali troverà nella necessità di ricostruzione a basso costo la propria fortuna [1]. L’industriale italiano muore nel 1956, la società diviene di proprietà belga, per poi essere presa in gestione dal gruppo svizzero della famiglia Shmidaney.
La fabbrica occupava 94.000 metri quadrati dell’area industriale del Ronzone, di 200.000 metri quadrati complessivi. Lo stabilimento rappresenta “l’America senza emigrare”: benessere, stabilità, un lavoro ben retribuito e orari flessibili.
LAVORARE ALLA ETERNIT DI CASALE MONFERRATO
Il reparto dal quale l’amianto veniva introdotto nel ciclo di produzione era quello delle materie prime, situato in un sotterraneo dove giungevano sacchi di juta privi di sigillatura che potevano contenere fino a 60 chili di asbesto [2]. Questi sacchi venivano aperti dai lavoratori manualmente, con un coltello, senza protezione; una volta aperti, l’amianto veniva messo a macinare nelle quattro molazze. La loro funzione era quella di disgregare quanto più possibile le fibre di amianto. Era compito dei lavoratori spurgare questi macchinari le molte volte in cui si bloccavano, smuovendo e grattando via l’amianto. Una volta macinato, il prodotto veniva stoccato. A queste fasi erano riservati cinque piani. Tale complesso comunicava direttamente con l’esterno. Negli ultimi 20 anni di vita dello stabilimento questo reparto fu abbandonato, chiuso senza nessun tipo di smaltimento. A seguito della chiusura di quest’area, l’amianto veniva inviato direttamente al reparto degli impasti, mentre quando i cinque piani di pre-stoccaggio erano ancora operativi, arrivava al reparto impasti trasportato dagli “uomini-bicicletta” su dei carretti simili a tricicli.
Il reparto degli impasti è quello all’interno del quale venivano realizzate le miscele: le impastatrici univano a secco amianto e cemento. Erano utilizzati macchinari diversi per la produzione di tubi e di lastre. Quando l’amianto a secco veniva inserito nel miscelatore, un’enorme nuvola di polvere offuscava l’intero settore; ogni giorno, a tutte le ore. “Era impossibile distinguere i volti dei colleghi”. Finito il turno ci si spolverava con l’aria compressa.
La miscela ottenuta veniva spinta da tubazioni a pressione o fino alle macchine-lastre o fino alle macchine-tubi, a seconda del prodotto da realizzare. Questo reparto era di tre piani. La miscela arrivava asciutta in un vascone dove, con acqua, veniva realizzato l’impasto, spinto poi sul retro della macchina, dove c’erano tre vasconi nei quali ruotava un cilindro di pescaggio ricoperto da una rete metallica, sopra la quale venivano adagiate le fibre d’amianto, per poi essere trattate e dosate. In questo reparto le macchine erano in funzione 24 ore al giorno.
Le lastre, una volta fatte e messe a riposo, venivano rifinite nel reparto Petralit, un “girone dantesco” dove venivano effettuate le lavorazioni manuali a secco. La polvere era una presenza quotidiana. Per quanto riguarda i tubi, una volta terminato il prodotto e lasciato riposare facendolo ruotare ogni 24 ore, veniva calato nel piano sotterraneo, in un reparto angusto con scarsissima illuminazione ed estremamente umido, dove veniva lasciato stagionare in vasche colme d’acqua. Una volta estratto, il tubo veniva introdotto nel reparto tornitura, comunicante con quello delle vasche, che dunque non era esente dalle scie di asbesto. La tornitura avveniva a secco, disperdendo una grande quantità di polvere.
Se la nebbia offuscava l’intera fabbrica, nei reparti più nocivi, al termine del turno ci si trovava di fronte ad una montagnola di polveri di tornitura alta oltre un metro. Solamente negli ultimi anni di produttività dello stabilimento, quando l’imperativo era quello della cosiddetta “lavorazione sicura” dell’amianto, sono state prese delle minime precauzioni, tra cui l’installazione di ventoline che aspiravano le polveri di tornitura e avrebbero dovuto filtrarle per renderne possibile il riciclo, rilasciando nell’ambiente aria pulita. Per il loro corretto funzionamento sarebbe stata necessaria una manutenzione quotidiana, ma la dirigenza decise per una pulizia settimanale. Non era previsto un sistema di vero e proprio smaltimento delle polveri, che in questo modo venivano semplicemente espulse all’esterno della fabbrica. La polvere si disperdeva facilmente nell’area di Casale Monferrato, basti pensare che il portone del reparto a pressione comunicava con l’esterno e veniva aperto ogni quarto d’ora per far circolare i camion. Nelle stagioni calde veniva lasciato aperto tutta la giornata.
Recipienti, contenitori, tegole, canne fumarie e pezzi speciali venivano realizzati manualmente nel magazzino Po, che lavorava pasta cemento fresca e morbida: la lavorazione in umido rilasciava meno polveri, anche se poi la merce veniva carteggiata e rifinita a secco. In questo reparto era prevalente la presenza femminile. Gli operai del Po erano chiamati “operai canterini”. Cantare era l’unico modo per non pensare alla fatica del lavoro, che qui era a cottimo: il compenso incrementava all’aumentare della produzione. Nonostante questo fosse il reparto meno nocivo, passava di lì il trenino che portava l’amianto in fabbrica. Le lavoratrici, per evitare che i capelli si ingrigissero per la polvere, utilizzavano un fazzoletto in testa e l’altro in volto. Sono diverse le testimonianze di ex lavoratrici che oggi temono per la salute dei propri figli, allattati tra un turno e l’altro con la tuta ancora addosso.
Tutto ciò che veniva prodotto all’interno dello stabilimento veniva stoccato nei magazzini di piazza d’Armi. Le operaie apponevano i timbri sul materiale che giungeva al deposito, mentre agli uomini spettava il compito di scaricare i camion. Questi camion portavano tubi appena torniti e lastre molate, attraversando la città senza alcuna copertura del carico, con il conseguente rilascio di residui di lavorazione lungo il tragitto.
Un’ulteriore attività riguardava il riciclaggio di lavorazioni errate, che fino ai primi anni Sessanta venivano gettate in una discarica alla quale molti casalesi si recavano alla ricerca di pezzi ancora in buono stato. Con l’introduzione del re-utilizzo, poco per volta le merci venivano portate sotto a un capannone senza mura, dove una ruspa le frantumava 24 ore al giorno, rilasciando grandi quantità di polvere. Prima di essere reintrodotti nel ciclo produttivo, i frammenti venivano portati al mulino Hazemag per la macinazione. L’impianto era altamente nocivo: operava a cielo aperto ed essendo quello di Casale l’unico stabilimento che recuperava materiali di scarto, si faceva carico della macinazione degli scarti di tutte le altre fabbriche Eternit d’Italia. Alla fine di ogni turno gli operai uscivano, completamente bianchi. La tuta blu, ricoperta dalla patina di amianto, andava a casa con l’operaio. Tornata polvere, la merce difettosa veniva reintrodotta nel ciclo produttivo.
RICATTI E MONETIZZAZIONE DEL RISCHIO
Alla Eternit era nocivo anche il clima di lavoro ai quali erano costretti i lavoratori. La fabbrica metteva in atto una politica paternalistica. Questo atteggiamento di benevola superiorità della dirigenza rispetto a chi all’Eternit ci lavorava, si traduceva nell’imposizione di regole di condotta paragonabili a vere e proprie forme di sfruttamento e di ricatto. Già dagli anni Quaranta l’azienda era pienamente al corrente dei rischi amianto-correlati. Non era un caso che gli operai dei settori più pericolosi avevano lo stipendio incrementato di circa ventimila lire rispetto agli altri. Questa cifra, simbolica rispetto alla reale portata del rischio, era una sorta di “indennità di polvere”.
All’Eternit si “prendeva la polvere” [3]. Ammalarsi era vissuto quasi come una medaglia al valore dopo anni di duro lavoro. Era considerato normale: una ovvia conseguenza di un duro lavoro. L’operaio, lavorando, poteva infortunarsi, ammalarsi e anche morire. I dirigenti mettevano in atto ricatti e minacce, specialmente contro i lavoratori dalle voci più sonore, ai quali, per esempio, eliminavano l’indennità di polvere. Nicola Pondrano racconta come per prima cosa, visto che a due mesi dall’assunzione faceva già parte del Consiglio di Fabbrica dell’Eternit, gli bloccarono la carriera da tecnico di laboratorio, de-mansionandolo. L’azienda, inoltre, erogava un litro d’olio d’oliva al mese per ogni lavoratore, ma “se non siete bravi, l’olio ve lo togliamo”. Altra ritorsione nei confronti dei lavoratori non innocui era quella di isolarli dal resto degli operai. Coloro che dimostravano “insofferenza”, venivano collocati in un reparto chiamato “il Cremlino”. I lavoratori lo collocano in diversi reparti dell’azienda: secondo alcuni era il reparto della catramatura, secondo altri quello dove si tenevano i tubi a pressione. Il Cremlino non era un luogo fisico, ma una condizione punitiva di lavoro duro, usurante e umiliante, che andava dalla pulizia delle latrine alla pulizia dei filtri delle polveri. Spesso i turni punitivi erano durante le ore notturne, quando la stanchezza era sempre in agguato e c’era il rischio di cadere nei contenitori da otto metri di altezza. Altra pratica di ricatto un po’ più velata era quella di spostare i lavoratori che manifestavano l’intenzione di licenziarsi in reparti meno nocivi, più “confortevoli”. Questo apparente favore in realtà era un modo di revocare il diritto del lavoratore all’indennità di rendita di passaggio.
LA LOTTA ALLO STABILIMENTO
Nel 1976 viene istituita all’interno dello stabilimento casalese la commissione ambientale del Consiglio di Fabbrica, che decise di effettuare indagini ambientali per verificare la concentrazione di fibre d’amianto con propri periti. Uno sciopero di 87 ore fa sì che i lavoratori ottengano modifiche al processo di lavorazione, come l’imposizione di mascherine di carta, l’adozione di ventole e cappe aspiranti. Bastarono questi minimi miglioramenti per portare le testate dei giornali locali ad esultare: “All’Eternit l’amianto non nuoce più”. Come se quelle piccole migliorie avessero annullato il rischio amianto-correlato. L’azienda, coerentemente con l’azione intrapresa dalla società europea, metteva in atto campagne di contro-informazione per difendersi dalle accuse del Consiglio di Fabbrica, per esempio imponendo ai lavoratori di non fumare con campagne che ammonivano “fumare fa male” per limitare il numero di malati, visto che fumare accelerava gli effetti dell’amianto. Lo scopo di questi slogan era quello di relativizzare la portata delle informazioni: l’amianto nuoce alla salute, sì, ma solo se si fuma, o solamente se lavorato non in sicurezza.
Sul finire degli anni Settanta, i risultati emersi da un’indagine condotta all’interno dello stabilimento (in preparazione dei quali l’Eternit casalese aveva disposto pulizie straordinarie ed alternato il ciclo produttivo in modo da ridurre lo spargimento di polvere) portarono l’INAIL a ridurre il premio corrisposto per il rischio amianto perché, eccetto un paio di reparti, non esistevano più spazi altamente nocivi nella fabbrica. Queste decisioni accesero la reazione della Camera del Lavoro; la mobilitazione dei lavoratori comincia a essere seguita dai giornali e a catalizzare l’attenzione dei casalesi, dando vita a un primo dibattito tra chi ritiene necessaria una presa di posizione contraria alla dirigenza Eternit e chi, invece, sostiene che la Eternit serve per dare lavoro ai casalesi. Nel 1983 la CGIL promuove una causa civile nei confronti dell’INAIL conducendo un’indagine con propri periti. Nonostante le macchine spente e i reparti lucidati, da questa seconda indagine è chiaro che l’amianto è ovunque e questo porta alla vittoria del processo, accendendo l’attenzione della stampa. In concomitanza di questi eventi il Pubblico Ministero Guariniello e Terracini, epidemiologo presso l’Università di Torino, analizzano i sessantuno casi di mesotelioma diagnosticati a Casale Monferrato tra il 1973 e il 1982. Di questi, soltanto il 39,3% coinvolgeva lavoratori a contatto con l’amianto. Le informazioni relative al doppio volto dell’amianto faticano a rimanere taciute. Iniziano le prime mobilitazioni, che stanno attirando l’attenzione della stampa. I vertici dell’industria europea dell’amianto, riunitisi nell’AIA [4], decidono di lasciar fallire il gruppo Eternit italiano. Il 4 giugno 1986 lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato è dichiarato fallito. L’azienda pare voler riprendere l’attività nel 1987, ma un’ordinanza emessa dal sindaco Riccardo Coppo, che vieta su tutto il territorio casalese l’impiego di amianto, lo impedisce.
Di amianto si può morire anche se non si lavorava alla Eternit. Questa battaglia non trova un immediato consenso. “Ci dicevano che era colpa nostra se la Eternit era chiusa”, mi viene detto durante le interviste. A non far comprendere subito la reale entità del rischio era la campagna di disinformazione messa in atto dalla Eternit, che passava dall’affermare l’inesistenza del rischio al sostenere la sua avvenuta risoluzione. A seguito dei risultati epidemiologici ottenuti, la pretura di Casale avvia un’indagine tesa ad accertare la responsabilità penale di tali morti. La fase istruttoria si concluderà dopo cinque anni con il rinvio a giudizio dei quindici dirigenti della società italiana. I capi di accusa sono omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime aggravate. Il processo si chiude nel 1993 con la condanna di quattro degli imputati.
Con la Legge 257 del 1992, la norma casalese di messa al bando dell’amianto viene estesa a tutta Italia, che per prima in Europa ne impedisce l’attività di estrazione, la lavorazione e l’impiego.
NOTE
[1] Altopiedi Rosalaba, Un caso di criminalità di impresa: l’Eternit di Casale Monferrato, Torino, L’Harmattan Italia, 2011.
[2] Quando si parla di asbesto o amianto, ci si riferisce a un insieme di minerali costituiti da sottilissime fibre.
[3] Linguaggio gergale utilizzato dai lavoratori e dalle lavoratrici dell’Eternit. Prendere la polvere significava ammalarsi di asbestosi: malattia polmonare cronica conseguente all’inalazione di fibre di asbesto.
[4] L’AIA è l’Associazione Internazionale per l’Amianto, nata dall’intento delle industrie internazionali produttrici di amianto di garantirsi profitti in un regime di oligopolio, anche oscurando ed occultando informazioni in merito alla nocività del minerale, informazioni delle quali erano a conoscenza già dagli anni Quaranta.
——————————————-
IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO I PIEDI NON SONO PROTETTI
Da: PuntoSicuro
01/02/18
di Tiziano Menduto
Esempi di infortuni in cui è stata rilevata l’assenza di idonei dispositivi di protezione dei piedi. Gli infortuni, i fattori causali e la prevenzione con particolare riferimento alle calzature per i rischi elettrici e i rischi termici.
I piedi sono una delle parti del corpo più esposta a rischi, di varia tipologia e gravità. E diverse puntate della rubrica “Imparare dagli errori” hanno raccontato in questi anni i tanti infortuni professionali che possono riguardare i piedi nei luoghi di lavoro, specialmente in assenza degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), le scarpe di sicurezza.
Torniamo a parlarne oggi con specifico riferimento ad infortuni in cui questi DPI non sono stati forniti o non sono stati utilizzati dai lavoratori.
Come sempre le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto nel reparto fusione.
Un operatore nel reparto fusione è intento a manovrare, a mezzo di un carro ponte, la siviera (recipiente per metallo fuso) dove si deve inserire dal forno il materiale fuso.
Nel corso dell’operazione, a travaso quasi ultimato, un improvviso deflusso della colata urta la traversa superiore della siviera e un getto della colata colpisce agli arti inferiori l’operatore procurandogli lesioni al piede destro. Infatti del materiale incandescente è penetrato all’interno della calzatura e non sono stati forniti idonei DPI.
Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:
- DPI non idonei;
- siviera mal posizionata per contenere possibili deflussi improvvisi.
Il secondo caso riguarda un infortunio relativo ai rischi elettrici.
Un lavoratore interviene in un quadro elettrico per un guasto al motore elettrico di un impianto di aspirazione dell’impianto di betonaggio. Disattiva il sistema di sicurezza del quadro e con il cacciavite spinge un interruttore che ha causato dell’incollaggio dei contatti di un secondo interruttore provocando un corto circuito “franco”. Viene investito dalla fiammata alla mano destra, al braccio destro, alla spalla destra e al volto.
L’infortunato doveva provare le apparecchiature elettriche con dei tester e inoltre era sprovvisto dei vari DPI (visiera, guanti, giubbotto, tuta e scarpe) dielettrici.
Due i fattori causali:
- mancanza di DPI dielettrico;
- l’infortunato prima di operare non ha provato le apparecchiature elettriche con dei tester e intervenendo sul quadro si è generato un arco elettrico.
Il terzo caso riguarda un infortunio dovuto alla perdita di equilibrio di un lavoratore.
Si devono trasportare paletti in cemento armato e un lavoratore è posizionato sul cassone di un rimorchio trainato da un trattore.
A un tratto il lavoratore perde l’equilibrio (non gli erano state fornite scarpe di sicurezza) e a causa della mancanza di sponde nel cassone cade a terra procurandosi la frattura della gamba sinistra.
Questi i fattori causali rilevati:
- cassone rimorchio senza sponde;
- il lavoratore non indossando scarpe di sicurezza perde l’equilibrio.
Come si può vedere dagli infortuni presentati, idonee scarpe di sicurezza nei luoghi di lavoro sono necessarie non solo per i rischi meccanici di schiacciamento, urti e tagli degli arti inferiore. Sono molti i rischi lavorativi che possono essere evitati o resi meno gravi attraverso l’utilizzo di calzature di sicurezza adeguate ai rischi affrontati. Ad esempio rischi chimici e biologici (sversamento di prodotti chimici, contatto con materiali biologici, ecc.), rischi fisici (umidità, acqua, temperatura, ecc.), rischi elettrici e termici.
Per parlare di calzature antinfortunistiche in relazione ad alcuni rischi non meccanici, ci soffermiamo sul contenuto del progetto multimediale Impresa Sicura, un progetto elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia Romagna e INAIL.
Nel documento “ImpresaSicura_DPI”, correlato al progetto, sono riportati alcuni requisiti di protezione aggiuntivi alle dotazioni di base minime delle calzature antinfortunistiche, requisiti che possono essere necessari per proteggere da specifici rischi.
Ad esempio, riguardo al rischio elettrico, si possono indossare:
- calzature conduttive o almeno antistatiche: quelle conduttive (sigla C, classi I o II), sono necessarie quando occorre ridurre al minimo le cariche elettrostatiche potenziali causa di scintille (ad esempio nella manipolazione di esplosivi) e invece, al contrario, sono da evitare accuratamente se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse elettriche prodotte a esempio da elementi sotto tensione;
- calzature isolanti o dielettriche (sigla I, pittogramma con doppio triangolo) sono solo di classe II, cioè interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o di materiale polimerico (cioè interamente formate) e sono necessarie quando si ha rischio di scosse elettriche (ad esempio nelle installazioni elettriche o lavori elettrochimici, se ci sono apparecchi elettrici danneggiati con elementi sotto tensione).
Riguardo invece ai rischi termici, si possono avere calzature che isolano il piede dal calore (HI), da usare quando si prevede presenza di forte calore (ad esempio se si deve calpestare una superficie calda, come nei lavori di bitumazione stradale o nella siderurgia), oppure, al contrario, calzature che isolano dal freddo (CI) (ad esempio per lavori all’esterno a basse temperature o industria alimentare con conservazione a freddo).
Esistono, infine, anche protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:
- al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici;
- al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad esempio lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.): sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena e un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova); è importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione; il livello di protezione dipende dalla velocità della catena;
- agli incendi: le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (Hln) che indica il livello di protezione relativo all’isolamento dal caldo.
Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo sono state presentate le schede numero 4736, 5943 e 5826, è consultabile all’indirizzo:
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp
Il documento “ImpresaSicura_DPI” di EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia Romagna e INAIL è scaricabile all’indirizzo:
http://www.impresasicura.org/dpi/completa/media/pdf/DispositiviProtezioneIndividuale11.pdf
——————————————-
SULL’UTILIZZO PRIORITARIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Da: PuntoSicuro
di Gerardo Porreca
05/02/18
Nei lavori in quota contro il rischio di caduta dall’alto vanno utilizzati prioritariamente i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali è consentito se la protezione collettiva sia tecnicamente impossibile e per esposizioni di breve durata.
Due le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro messi in evidenza dalla Sentenza n. 2335 del 19 gennaio 2018 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV, chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro per l’infortunio occorso a un lavoratore che, salito con i ramponi su di un palo in legno per sostituire un cavo telefonico, è caduto da una altezza di 4 metri per la rottura del palo stesso alla sua base.
A difesa dal rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota, ha messo in evidenza la Suprema Corte, vanno previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e utilizzati prioritariamente i DPC limitando il ricorso a quelli di protezione individuale solo nel caso che sia tecnicamente impossibile l’utilizzo di quelli collettivi e nel caso di limitati livelli di rischio o di una breve esposizione allo stesso.
Nell’esecuzione delle misure di sicurezza, inoltre, è necessario attenersi alle soluzioni indicate nel DVR e alle protezioni in esso indicate. Nel caso particolare della sentenza riguardante la presenza di un rischio di caduta dall’alto, era stato previsto per il lavoro da effettuare in quota il ricorso a una piattaforma elevabile mentre il lavoratore si è infortunato arrampicandosi sul palo utilizzando dei ramponi e una cintura che erano i mezzi che venivano normalmente utilizzati per tale tipo di lavoro.
IL FATTO, L’ITER GIUDIZIARIO E IL RICORSO IN CASSAZIONE
Il Tribunale ha dichiarato la legale rappresentante di una società responsabile del reato di cui all’articolo 590, comma 3 (lesioni personali colpose), in relazione all’articolo 583, comma 1 (circostanze aggravanti) del Codice Penale e, concesse le attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
In particolare all’imputata veniva addebitato di avere cagionato, nella sua qualità di legale rappresentante della società, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a un dipendente lesioni personali gravi tali da determinare incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni (specificamente giudicate guaribili in 148 giorni).
Più in particolare, in conseguenza della violazione di cui agli articoli 29, comma 1 del D.Lgs. 81/08, per aver elaborato un DVR incongruo che, non tenendo conto e non valutando tutti i rischi relativi alle cadute dall’alto, non indicava le misure di prevenzione e protezione da adottare e 111, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 per non aver fornito al lavoratore l’idonea attrezzatura atta a garantire condizioni di lavoro sicuro contro le cadute dall’alto (quale ad esempio il cestello autosollevante), all’imputata era stato addebitato di avere omessa l’adozione di idonee misure di prevenzione, ragion per cui il lavoratore, nel mentre operava legato su un palo per sganciare i vecchi raccordi telefonici per poi sostituirli, essendosi il palo spezzato alla base, era caduto a terra da un’altezza di 4/5 metri e si era provocata le lesioni. Tutto ciò con le aggravanti dell’essere la lesione grave (avendo determinato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo non inferiore a 40 giorni) e dell’essere il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 62 (circostanze attenuanti comuni) del Codice Penale in ragione dell’intervenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa e ha rideterminata la pena finale inflitta in 7.500,00 Euro di multa, così sostituendo la corrispondente pena detentiva di mesi uno di reclusione. Ha revocato altresì, su richiesta dell’appellante, il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermata, nel resto, la decisione impugnata.
Nei giudizi di merito era risultato accertato che il lavoratore infortunato era un operaio dotato di grande esperienza nello svolgimento dell’intervento manutentivo cui era stato addetto (cosiddetta mansione di “guardafili”), e l’operazione che doveva fare il giorno dell’infortunio consisteva nella sostituzione dei cavi di una linea telefonica posti su dei pali in legno che avrebbero dovuto essere staccati per la loro successiva sostituzione. Per adempiere a tale compito il lavoratore, dopo avere provveduto a saggiare la tenuta del palo secondo le disposizioni impartite dalla società, si era arrampicato su di esso avvalendosi dei soli strumenti fornitigli dall’azienda, ovvero dei cosiddetti ramponi montapalo e della cintura di sicurezza allorquando, mentre era quasi alla sommità, lo stesso palo si era improvvisamente spezzato, determinando, così, la sua caduta da un’altezza di 4/5 metri, non essendo assicurato ad alcun idoneo dispositivo di trattenuta.
I giudici di merito avevano fondato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputata risultando comprovato che la società aveva omesso di fornire al lavoratore infortunato le misure di protezione collettiva prioritariamente previste nel DVR nel caso di salite ad altezze superiori a due metri ovvero “l’utilizzo, in via prioritaria, di un’autopiattaforma oppure, in alternativa, di una scala quando l’utilizzo di tale mezzo fosse stato tecnicamente impossibile o non necessario in considerazione del limitato livello di rischio o dalla breve durata dell’intervento); l’utilizzo dei ramponi e della cintura di sicurezza era, invece, considerata una modalità del tutto residuale”.
Nel caso in esame era risultato tecnicamente possibile l’utilizzo dell’autopiattaforma in quell’occasione, in ragione delle favorevoli condizioni dei luoghi, risultando le palificazioni collocate in un terreno pianeggiante e solido, facilmente accessibile a mezzi meccanici. I DPI erano divenuti, nella prassi, i soli mezzi ordinari di protezione, non risultando disponibile nessuno dei DPC che avrebbero dovuto essere impiegati secondo il prestabilito ordine di priorità indicato nel DVR.
IL RICORSO IN CASSAZIONE E LE MOTIVAZIONI
L’imputata ha ricorso alla Corte di Cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia chiedendo l’annullamento della sentenza. Lo stesso ha evidenziato che dagli esiti del dibattimento era risultato comprovato che lo SPRESAL dell’ASL aveva avallato le procedure aziendali previste nel DVR, così come rielaborato dalla società a seguito della prescrizione ex articolo 20 del D.Lgs. 758/94. Ha specificato inoltre che il DVR., pur continuando a prevedere, in via prioritaria, l’adozione di forme di protezione collettiva, ha tuttavia escluso la possibilità di ricorrere alla piattaforma perché, nella maggior parte dei casi, non sarebbe stato possibile avvicinare il mezzo al palo. Lo SPRESAL, secondo il ricorrente, aveva considerato accettabile fronteggiare il rischio di caduta dall’alto per chi opera sui pali con l’adozione delle misure di protezione individuali (ovvero dall’attrezzatura costituita dai ramponi e dalla cintura di sicurezza) e l’evento andava ascritto a una mera fatalità atteso che la rottura del palo a 115 cm da terra era anomala e senza che vi fosse stato alcun segno premonitore esterno della compromissione del legno.
LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha fatto presente che nel caso in esame la Corte Distrettuale aveva puntualmente rivalutato e valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, puntualmente esaminate e rigettate, era giunta, con motivazioni congrue e logiche, alle medesime conclusioni in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputata. I giudici di secondo grado avevano infatti ribadito che il datore di lavoro aveva messo a disposizione dei lavoratori solo DPI che, invece, nel DVR erano previsti in via del tutto residuale (ramponi montapalo e cintura di sicurezza), ovvero allorquando, in ragione di peculiari situazioni (ad esempio pali posizionati su terreni estremamente impervi), non fosse possibile avvalersi degli altri sistemi (in via graduata autopiattaforma e scale), da utilizzarsi prioritariamente.
Nel caso in esame la pianeggiante conformazione dei luoghi, ha osservato la Corte Suprema, avrebbe certamente consentito l’utilizzo dell’autopiattaforma, così scongiurando i rischi di caduta dall’alto correlati alla rottura del palo per effetto delle sollecitazioni derivanti dall’arrampicata del lavoratore, donde l’addebito a titolo di colpa di quanto verificatosi a causa del mancato utilizzo di un mezzo meccanico per portare in quota l’operaio per cui ha rigettato il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Sentenza n. 2335 del 19 gennaio 2018 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV è consultabile all’indirizzo:
——————————————-
LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER I LAVORATORI IMMIGRATI
Da: PuntoSicuro
08/02/18
I principali fattori di rischio per i lavoratori stranieri nei settori delle costruzioni e agricolo: le particolarità e l’importanza di una corretta formazione.
Pubblichiamo alcune misure preventive per i rischi dei lavoratori stranieri impiegati nei settori delle costruzioni e agricoltura tratte dalla scheda n. 10 “Lavoratori immigrati” pubblicata da INAIL.
Il cantiere edile rappresenta lo scenario principale degli infortuni mortali di lavoratori immigrati, in quanto, come noto, il settore delle costruzioni continua a rappresentare uno dei maggiori ambiti di inserimento lavorativo della popolazione migrante presente in Italia, sia per l’elevata capacità di assorbimento di manodopera sia perché l’ingresso lavorativo ai livelli più bassi non richiede specifiche competenze professionali. Per quanto attiene alle misure di prevenzione, in merito alle cadute dall’alto dell’infortunato (pari al 33,3%), i lavori in quota devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure previste dagli articoli 105 e 117 del D.Lgs. 81/08.
A queste attività, particolarmente pericolose, il legislatore ha dedicato il Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e in quota”. Nell’ambito di queste norme si annovera anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi o individuali.
Dall’analisi svolta, si è evidenziato che laddove veniva riscontrata una criticità relativa all’impiego di dispositivi di protezione, nel 54% dei casi questa era riconducibile al mancato uso di dispositivi anche se a disposizione del lavoratore. Più nello specifico, nella quasi totalità di questi casi il dispositivo non utilizzato era la cintura di sicurezza individuale.
Tuttavia, si sottolinea che l’impiego dei suddetti sistemi prevede una competenza da parte dei lavoratori ai quali, così come previsto dalla normativa, deve essere erogata una specifica formazione che deve risultare chiara ed efficace, contemplando gli eventuali limiti di natura linguistica che il cittadino straniero può evidenziare nella comprensione (articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08).
L’infortunio causato dalla caduta dall’alto di gravi rappresenta la seconda modalità degli incidenti mortali occorsi ai lavoratori stranieri. Tali accadimenti dovuti spesso a errori di procedura, possono essere ridotti attraverso sia l’adozione di opportune procedure per la movimentazione dei carichi, in particolare prevedendo la messa in sicurezza del personale addetto alla movimentazione e di tutto il personale comunque interessato all’operazione in corso, che prevedendo adeguati interventi di formazione informazione e addestramento, non ultimo attraverso un’attenta azione di vigilanza affinché le corrette procedure di lavoro vengano effettivamente attuate.
Come rilevato, il settore agricolo è spesso teatro di incidenti mortali per i cittadini stranieri. Per quanto riguarda la modalità di accadimento prevalente, si evidenzia che i rischi più gravi a cui è esposto l’operatore si verificano alla guida del trattore. Questi sono rappresentati sicuramente dai ribaltamenti trasversali e/o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad esempio per le attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno e così via.
Allo stato delle conoscenze attuali i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di ribaltamento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati a evitare che il verificarsi di un evento pericoloso possa comportare conseguenze per l’incolumità del lavoratore:
- dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ovvero una struttura installata direttamente sul trattore avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un utilizzo normale;
- dispositivo che trattiene l’operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore.
I sistemi di protezione passiva per conducenti dei trattori si basano sul principio di trattenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” o “zona libera”. In caso di ribaltamento il rischio, per l’operatore, di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore, e il suolo può essere escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione.
Degno di attenzione, sempre in ambito agricolo, anche il triste fenomeno dei decessi avvenuti a causa di colpi di calore. E’ bene sottolineare che la prevenzione di tali eventi si realizza, soprattutto, attraverso la programmazione dei lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l’orario mattutino e preserale.
Inoltre, è indispensabile garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro: bere acqua fresca e sali minerali non solo abbassa la temperatura interna del corpo, ma soprattutto consente al fisico di recuperare i liquidi persi con la sudorazione.
I luoghi di lavoro devono quindi essere, regolarmente, riforniti di bevande idrosaline e acqua per il rinfrescamento dei lavoratori. E’ importante assumere liquidi frequentemente durante il turno di lavoro, evitando le bevande ghiacciate e integrando con bevande idrosaline, in special modo se si suda molto. Il lavoratore deve, inoltre, indossare mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante. Devono essere previste pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro.
I fattori di rischio sin qui evidenziati, richiedono interventi non solo di ordine tecnico-normativo, ma anche di valutazione culturale e sociale del fenomeno in analisi. La lingua e le differenze culturali legate alla provenienza, rappresentano un elemento di possibile condizionamento della percezione e rappresentazione del rischio, delle quali occorre tener conto in una progettazione efficace dei corsi di formazione per stranieri in materia di salute e sicurezza. Del resto è lo stesso legislatore a porre l’attenzione sulla comprensione concettuale e linguistica dei contenuti della sicurezza sul lavoro, prevedendo percorsi di informazione e formazione facilmente comprensibili e, in particolare per i lavoratori immigrati, la verifica preliminare della lingua utilizzata negli stessi percorsi.
Tale orientamento è specificato anche nell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che ha regolamentato l’attività di formazione rivolta ai lavoratori stranieri: nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione.
Dunque, l’integrazione del lavoratore straniero sul piano socio-lavorativo e su quello più specificatamente legato alla sicurezza sul lavoro è facilitato dall’apprendimento della lingua e del contesto culturale di riferimento. Assicurare ai lavoratori stranieri una formazione adeguata che tenga conto delle peculiarità degli stessi, attraverso percorsi con contenuti di intuitiva e immediata acquisizione e facilitando la comprensione del messaggio con didascalia nelle lingue più diffuse tra la manodopera straniera, che in questi ultimi anni è sensibilmente aumentata nella cantieristica, risultano essere misure funzionali ai fini della prevenzione negli ambienti di lavoro. E questo perché gli obiettivi della formazione sono il sapere, il saper fare, il saper essere; essi comportano una serie di cambiamenti nei confronti dei soggetti destinatari e nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La formazione deve essere considerata un investimento da cui ricavare profitto in termini di capitale anche sociale. Infatti l’investimento in formazione e in sicurezza è sempre profittevole e conveniente.
La scheda n. 10 “Lavoratori immigrati” pubblicata da INAIL è scaricabile all’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-lavoratori-immigrati.pdf